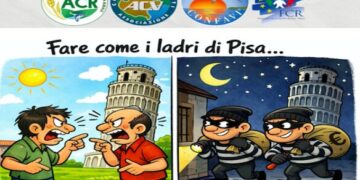Non solo un predatore
In un’epoca in cui la cucina riscopre il selvatico, la volpe torna a far parlare di sé. Non come icona fiabesca o nemico del pollaio, ma come ingrediente raro, controverso e profondamente legato alla cultura rurale. Un tempo, nelle valli alpine e nelle campagne lombarde, la volpe non era solo predatore: era anche preda. E talvolta, piatto.
Tradizione o provocazione?
La carne di volpe non ha mai avuto larga diffusione. Troppo odorosa, troppo selvatica, troppo difficile da trattare. Eppure, in alcune zone d’Italia e d’Europa, veniva cucinata con rituale attenzione: lunghe marinature in vino rosso, spezie forti, cotture lente. Il risultato? Un piatto da caccia estrema, riservato a chi non temeva il gusto della foresta. In Francia, la volpe è citata nei ricettari del XVIII secolo. In Romania e nei Balcani, ancora oggi alcuni cacciatori la consumano, soprattutto in contesti rituali. In Italia, la sua presenza in cucina è più rara, ma non del tutto assente: testimonianze orali parlano di stufati “di necessità” durante la guerra, o di piatti preparati per sfida, per orgoglio venatorio.
Una carne che divide
Dal punto di vista gastronomico, la volpe è una sfida. La sua carne è fibrosa, intensa, con un odore penetrante che richiede trattamenti lunghi e sapienti. Non è carne da tutti i giorni, né da tutti i palati. Ma proprio per questo, può diventare simbolo di una cucina che osa, che racconta, che non si vergogna delle proprie radici. Cucinare la volpe oggi non significa promuovere la sua caccia indiscriminata. Al contrario, può essere occasione per riflettere sul ruolo del selvatico nella nostra alimentazione, sulla gestione faunistica, sull’equilibrio tra uomo e natura. In un mondo dove si mangia cinghiale, capriolo, lepre e piccione, perché la volpe dovrebbe essere tabù? La risposta non è semplice. Ma forse, proprio per questo, vale la pena porla (fonte: Federcaccia Nucleo di Magenta “Eligio Colombo”).