Una pronuncia dirompente
A memoria, non ricordiamo nell’ultimo ventennio altra pronuncia sulla caccia di un TAR tanto dirompente, quanto la sentenza della sezione IV del TAR Lombardia di Milano (presidente Gabriele Nunziata, consigliere estensore Antonio De Vita) n. 1516 pubblicata il 2 maggio scorso, con la quale in accoglimento del ricorso della lac (incidentalmente minuscolo) il Consiglio regionale dovrà provvedere a vietare con effetto immediato la caccia su 475 valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna sul territorio regionale. In buona sostanza, in un numero di valichi – o, per meglio dire, di siti ora giuridicamente ritenuti tali – di gran lunga più elevato della somma di tutti i valichi già formalmente istituiti nell’intera Penisola. Una situazione che solo pochi, inguaribili realisti avevano previsto e cui occorrerà necessariamente porre duraturo rimedio, nell’interesse non esclusivo, per quanto importante, dei soli cacciatori lombardi.
La partita non è chiusa
Il rischio è infatti l’apertura di scenari a cascata che potrebbero coinvolgere anche le altre Regioni con territori almeno in parte montani. Tutti si attendono che Regione Lombardia ricorra in appello al Consiglio di Stato contro questa sentenza chiedendone la sospensiva, una sorta di atto dovuto, anche perché la partita non è effettivamente chiusa. Di sicuro però il contenzioso amministrativo, comunque e quando finirà, non potrà sanare il vulnus di fondo, ovvero una norma di legge vetusta, quella dell’art. 21, comma 3 della 157, che vieta la caccia (vuol dire tutta, in ogni sua forma) per una distanza di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna. Oggigiorno simile disposizione generalista e generalizzata non ha più ragion d’essere: ammesso, peraltro, che 33 anni or sono tale ragione l’avesse (rileggendosi gli atti della XIII Commissione Ambiente del Senato dell’epoca, disponibili su internet, se ne può agevolmente individuare la paternità politica, che svela subito perché la norma sia così draconiana).
Problematiche sanitarie
Oggi, oltre a essere immotivatamente oltranzista contro l’attività venatoria, essa comporta molti e pesanti impatti negativi. Tutti, ad esempio, ben sappiamo quanto siano mutate nel nostro Paese la presenza e la distribuzione delle specie selvatiche e relative forme di prelievo: basti pensare all’ormai ubiquitario prelievo selettivo degli ungulati e al radicamento della caccia collettiva al cinghiale anche al Nord e al Sud dalla culla originaria del Centro Italia. Cacce che patiranno lo stop al pari di tutte le altre, d’attesa o vaganti che siano e a qualunque specie si rivolgano. E tacciamo per carità di patria sulle problematiche sanitarie e dei danni alle produzioni agro-forestali, che non potranno più essere fronteggiate anche avvalendosi della caccia, potendosi attuare nei valichi il solo controllo faunistico, con tutti i limiti organizzativi e operativi che lo contraddistinguono. La lettura della sentenza è, come sempre, fondamentale per tentare di comprenderla. Ad esempio, da nessuna parte vi si rinviene una definizione di “rotta di migrazione”, mentre sono molteplici i riferimenti alla definizione di “valico”, tratti peraltro dalla relazione del commissario ad acta Piero Genovesi. Non si tratta di un dettaglio, poiché la legge statale certamente dispone il divieto di caccia nei 1000 metri dai valichi, ma lo subordina alla condizione che siano “interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna”.
Le rotte migratorie
Ebbene, da nessuna parte si rinviene una definizione di cosa sia una rotta di migrazione: come si stabilisce? È dove transitano gli uccelli – e di quali specie – sia in autunno che in primavera? Basta che vi passino solo in una delle due stagioni dei loro movimenti annuali? E quanti ne debbono transitare? Ci sono cifre o percentuali minime o medie da tenere a riferimento, ed esse sono uguali o diverse fra le specie? Sulla base di quali serie storiche si può decidere? Le osservazioni fatte nel tempo sono standardizzate o eterogenee? Una rotta deve avere un’ampiezza minima/massima predeterminata per essere definita tale? Ci vorrebbero tempo e indagini scientifiche approfondite, in assenza dei quali (perché il TAR il tempo non lo concede) ogni crinale montano sembra diventare un potenziale valico interessato da rotte migratorie, approccio pericolosissimo poiché il divieto di caccia si estenderebbe (di fatto, in Lombardia, così è avvenuto) a superfici di decine di migliaia di ettari e non in siti puntuali e ben localizzati. È paradossale che il commissario ad acta, la cui competenza tecnico-scientifica non può essere messa in discussione, non abbia fornito una descrizione esaustiva di cosa siano le rotte migratorie e che, invece, il TAR si sia preso la briga di “sorvolare” su questo aspetto.
Il futuro
Altro punto, che ci sembra significativo anche se può passare inosservato: la sentenza dispone la possibilità, in futuro, di modificare in aggiunta o in sottrazione l’elenco degli attuali valichi, a seguito di uno studio scientifico opera di un organismo qualificato, che però “dovrà avvenire previa interlocuzione con le associazioni ambientaliste e di categoria che intendono essere coinvolte nel procedimento”. Tutto qui? No. Come il TAR ricorda in alcuni capoversi della sentenza, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 254/2022, anch’essa collegata alla storia infinita dei valichi lombardi, aveva sancito che il TASP da sottoporre a protezione compreso nel raggio di 1000 metri dai valichi montani, deve essere escluso dalle percentuali minime e massime di TASP da destinarsi a protezione della fauna selvatica ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge 157/92 e delle corrispondenti norme regionali. Infatti: “Diversa (rispetto al TASP da destinare a divieto di caccia in zona Alpi e nel restante territorio ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge 157/92, ndr) è la necessità di tutela che si profila sui valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dell’avifauna, che è funzionale solo a garantire il passaggio indenne delle specie migratorie.
Un consistente impoverimento della specie interessata
In questa prospettiva il divieto posto dall’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un’attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata. In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell’esistenza di rotte migratorie dell’avifauna.” La traduzione? In parole povere, le superfici sottratte alla caccia per effetto dei valichi devono essere aggiunte a quelle sottratte alla caccia per effetto dell’istituzione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, parchi e riserve naturali, ecc. cioè, non possono nemmeno parzialmente sostituirle e non si può “compensare” la superficie persa per la caccia a causa dei valichi, riducendo proporzionalmente la superficie già a divieto per effetto dei piani faunistico-venatori.
Aree alpine e prealpine
Così, neppure conta a quanto ammonti la corrispondenza dei valichi in termini di ettari misurati al suolo. Pertanto, quando le bocce saranno definitivamente ferme, si avranno percentuali di TASP a divieto di caccia ai sensi della pianificazione faunistico-venatoria regionale, costituite da oasi, ZRC, parchi e compagnia cantante e, in aggiunta, le percentuali a divieto derivanti dall’istituzione dei valichi. Al momento nelle aree alpine e prealpine, nonché appenniniche dell’Oltrepò, della Lombardia, le percentuali ove la caccia sarà effettivamente vietata sono perciò schizzate a livelli mai raggiunti in passato. Oltre al danno, ecco pertanto la stangata proveniente dalla giurisprudenza della suprema Corte che, in quanto tale, non è ricorribile, come disposto dalla Costituzione stessa. A questo punto, concludiamo con una semplice valutazione: al di là della necessità di individuare i “veri” valichi, ossia dove realmente passino rotte migratorie e non qualche manciata di tordi o frosoni, la sola strada percorribile per risolvere stabilmente la vicenda, riteniamo sia quella di una modifica della norma statale, se non abrogandola perlomeno diluendola per evitare il divieto di caccia generalizzato. Si muova il legislatore nazionale e lo faccia con la massima urgenza e accortezza possibili, impiegando lo strumento normativo più adeguato e più solido a disposizione, tenendo bene a mente l’incombenza della Direttiva Uccelli (non ignorabile), le pronunce della Corte costituzionale e la reazione dei soliti noti, che immaginiamo andranno a dolersi a Bruxelles paventando distruzioni immani degli uccelli migratori da parte dei cacciatori. È ben tempo, altrimenti non sarà mai più tempo.





















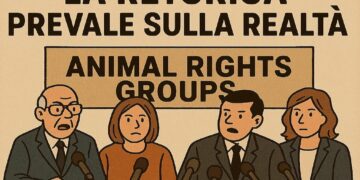

















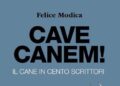






La caccia nei valichi montani minaccia tantissime popolazioni europee di piccoli passeriformi che in inverno sfuggono dal freddo delle aree nord europee per cercare ristoro in quelle mediterranee più a sud delle Alpi, dove vengono falcidiate dalle doppiette dei cacciatori subalpini bresciani e bergamaschi. Molti di questi sono veri criminali perché non risparmiano neppure piccoli uccelletti dal peso di pochi grammi, non sanno riconoscere le specie più preziose perché abbattono tutto ciò che vola ed utilizzano anche richiami elettroacustici vietati.
Sono loro che rovinano la passione dei cacciatori rispettosi, non le sentenze del TAR.